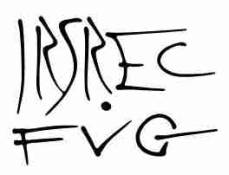A. Millo, Il disastro minerario del 28 febbraio 1940 alla miniera dell’Arsa
Scritto da Super User
Il disastro minerario del 28 febbraio 1940 alla miniera dell’Arsa
di Anna Millo**
Gli infortuni mortali hanno accompagnato da sempre il lavoro in miniera. E’ una constatazione amara, ma realistica: le maggiori conoscenze scientifiche e il progresso dei mezzi tecnici hanno contribuito nel corso del tempo ad alleviare, a ridurre, ma non ad estinguere il rischio. E’ questo l’aspetto più tragico della vita del minatore.
L’infortunio in miniera nella maggior parte dei casi si verifica come risultato finale di un processo cumulativo di fattori diversi, di una “combinata di forze”, come dicono i tecnici. La sciagura del 28 febbraio 1940 fu in effetti preceduta da una serie di infortuni di minore rilevanza e da incidenti mortali di minore entità quanto al numero delle vittime, episodi che tuttavia segnalavano come fosse in atto all’Arsa in quel periodo un preoccupante aggravio delle condizioni di lavoro e di mancanza di sicurezza. Nel 1937 si era registrato un incidente con 13 morti, seguito nel 1939 da un altro con 7 morti. Per gli anni 1936-37 siamo in possesso di una statistica che attestava un deciso aumento degli infortuni che, se non erano mortali, erano tuttavia causa di inabilità e di invalidità.
Questo andamento degli infortuni accompagna di pari passo la crescita industriale della miniera, che finalmente nella seconda metà degli anni Trenta nell’ambito della politica economica dell’autarchia aveva trovato il mercato interno pronto ad assorbire il suo prodotto, una lignite di elevato potere calorico, ma non di altrettanta buona qualità. E’ in questa rapida e disordinata espansione che si trovano le concause che hanno contribuito al disastro del 1940: l’aumento dei ritmi di lavoro, volti ad ottenere il massimo rendimento per operaio a scapito della manutenzione, necessaria alla sicurezza; l’inosservanza delle disposizioni di legge relative alla sicurezza, sulle quali in modo formale vigilava l’organo preposto, il distretto minerario, che, in caso di inadempienza, avrebbe avuto l’obbligo di riferirne al prefetto, quando tutte autorità dello Stato, nell’ambito del regime, erano tra loro concordi e solidali con la proprietà (rappresentata dallo Stato stesso) sull’intensificare gli obiettivi produttivi da perseguire; l’insufficiente prevenzione antinfortunistica, affidata all’iniziativa individuale del singolo minatore piuttosto che a misure e dispositivi a carico dell’azienda; l’attrezzatura impiegata, tecnicamente non sempre adeguata; infine, all’ultimo posto, ma non ultimi per importanza, i conflittuali rapporti tra dirigenza e lavoratori. E’ quindi, come si vede, un complesso di fattori diversi a trovarsi alle radici del disastro.
Al momento della sciagura del 28 febbraio 1940, che provocò 185 vittime e 149 feriti, erano presenti sul territorio diversi organi dello Stato, che vennero attivati a compiere inchieste ognuno per il settore di propria competenza ed è alla documentazione così prodotta che dobbiamo la maggior parte delle informazioni sull’accaduto. Innanzi tutto la magistratura (il procuratore del re, come allora si chiamava), il magistrato al quale spettava l’obbligo di legge di certificare il decesso e di avviare le procedure per identificare le vittime. In base a queste risultanze venne poi stilato l’elenco ufficiale dei nomi dei minatori deceduti, pubblicato nell’opuscolo a cura del Circolo Istria, un documento di impressionante lettura, che raccoglie nel suo insieme i frammenti di scarne biografie individuali. Questa lista, pur nell’essenzialità dei soli dati anagrafici riportati, ci apre un breve squarcio sulla durezza delle condizioni di vita dell’Istria di allora.
L’esplosione pare aver colpito in modo indiscriminato. Le vittime sono originarie per lo più di Albona, ma anche dell’Istria costiera e dell’Istria interna (ad esempio, di Montona, di Pisino) e non mancano neppure immigrati da altre regioni (un fenomeno questo resto ben conosciuto). Coloro che persero la vita, appartengono in maggioranza alla classe di età dei trentenni, giovani padri di famiglia spesso numerosa; in qualche caso sono membri dello stesso gruppo familiare, in quanto fratelli; spesso i celibi hanno a carico i genitori, così veramente il numero di coloro che nella disgrazia furono privati del loro sostegno affettivo e della fonte del loro sostentamento economico appare veramente grande. Sarebbe interessante poter appurare se si trattava di agricoltori, proprietari di piccolissimi appezzamenti, per i quali il salario in miniera rappresentava il vantaggio della continuità, a fronte delle incertezze dei lavori stagionali nell’agricoltura. I caduti possedevano in maggioranza le qualifiche professionali pù modeste. Se il numero di matricola riflette il progressivo ordine di assunzione, tra loro si trovano tanto quelli più vecchi ed esperti, quanto gli assunti più giovani (il più alto numero di matricola a comparire è il 9008). I più giovani erano nati nel 1921, avevano 19 anni, quindi dovremmo ritenere che fosse stato rispettato l’obbligo di legge che vietava le assunzioni in miniera prima dei 18 anni.
Tra le autorità presenti all’Arsa c’erano poi i carabinieri, alla cui attività investigativa, di ascolto attento del territorio, dobbiamo una serie di notizie sul clima di tensione che regnava all’interno della miniera in queli anni. La massa operaia - malgrado l’Arsa fosse stata posta sotto il controllo del Commissariato per le Fabbricazioni di guerra e in seguito militarizzata - era ancora in grado di organizzare manifestazioni spontanee di protesta contro la durezza delle condizioni di lavoro (come nel 1937, quando 300 furono gli operai coinvolti e 132 furono licenziati per ritorsione), mentre la dirigenza pareva intesa solo ad imporre una rigida e gerarchica disciplina interna e risultava incapace di suscitare relazioni maggiormente collaborative.
Infine troviamo il distretto minerario, l’organo statale di sorveglianza sulle miniere, cui spettò di redigere la vera e propria perizia tecnica sull’incidente, incarico che espletò con grande dovizia di cifre e di minuti particolari, ammettendo carenze di non poco conto e in particolare sottolineando un particolare decisivo, l’insufficiente ventilazione interna dei cantieri dove era avvenuta l’esplosione. Anche se poi la causa ultima dell’incidente fu attribuita - come si legge nella relazione - all’”imprudenza commessa da qualche minatore di aver acceso un fiammifero per accendere la sigaretta”. Questo fu dunque il responso ufficiale, che chiamava direttamente in causa i lavoratori - quanto meno in un concorso di colpa - nel disastro, fornendo un appiglio non secondario per assolvere nello stesso tempo la direzione della miniera ed anche lo stesso organismo tecnico, chiamato per conto dello Stato a sorvegliare sull’osservanza di regolamenti e prescrizioni. Quanto alle mosse dell’autorità giudiziaria, non ne siamo informati a sufficienza: dovremmo supporre che un procedimento fosse stato aperto, se non altro per archiviarlo. Non risulta comunque che sia stato formulato alcun rinvio a giudizio. L’ingresso dell’Italia in guerra, di poco successivo, rese ancora più urgente il fabbisogno di carbone e questa esigenza probabilmente favorì il silenzio calato sulla vicenda.
Quella del fumo in miniera da parte dei minatori era peraltro un’accusa diffusa negli ambienti padronali. Nella miniera di lignite di Ribolla nel Grossetano nel 1900 si era verificato uno scoppio di grisou che aveva provocato la morte di un operaio. Ai minatori scesi in sciopero per rivendicare la giornata di otto ore lavorative, la direzione rispose respingendo la richiesta e sostenendo che sul luogo dell’esplosione erano stati rinvenuti una pipa e dei fiammiferi.
Nel caso dell’Arsa, il responso sull’inosservanza dei regolamenti da parte degli operai è però largamente inattendibile e lo dimostra un’altra importante fonte di conoscenza in nostro possesso sulle condizioni dei minatori dell’Arsa. La dobbiamo al medico rovignese Mario Diana, che a questo tema dedicò nel 1938 la sua tesi di perfezionamento all’Università di Padova. Egli aveva potuto compiere una ricerca sul campo e nell’esporre i risultati testimoniava della presenza all’Arsa di malattie professionali, come malattie polmonari (l’insufficienza respiratoria causata dalle poleveri di carbone) e malattie cardio-vascolari e reumatiche, conseguenza delle cattive condizioni igieniche all’interno, dove gli ambienti erano caldi e umidi, così come all’esterno mancavano le docce per togliere dalla pelle i residui della polvere di carbone. Questa ricerca attesta come tra i lavoratori dell’Arsa, contrariamente ad una diffusa opinione, fosse assente l’alcolismo, perché gli stessi minatori non avrebbero tollerato comportamenti suscettibili di mettere a rischio la loro sicurezza. Se dunque vigeva all’interno della miniera una forma di controllo sociale che rendeva impossibili comportamenti individuali che potevano mettere a repentaglio la sicurezza di tutti, a maggior ragione dobbiamo ritenere che non fosse tollerato il fumare dentro le gallerie e i cantieri. Questo è dunque un segnale importante che ci permette di dubitare della versione ufficiale, che nella sua formulazione pare voler coprire responsabilità da ricercarsi a più alti livelli.
La ricerca di Mario Diana dimostra l’aumento degli infortuni avvenuto negli ultimi anni, costruendo una vera e propria serie statistica, e asserisce altresì la presenza nei minatori di uno stato di sovraffaticamento nervoso, conseguenza del costante pericolo in cui si lavorava nelle gallerie e del pesante ritmo di lavoro imposto dalla produzione. Dalle notizie in nostro possesso sembra di poter dire in effetti che la lavorazione a cottimo secondo il sistema Bedaux (per misurare le tonnellate-uomo per giorno) era stata all’Arsa più volte sospesa e ripresa, fino al definitivo abbandono avvenuto nel 1937, per motivi che non conosciamo, ma che fondatamente possiamo far risalire alle proteste dei lavoratori. Non è inverosimile che ciò sia potuto accadere. In un’altra miniera di lignite, alla Montecatini di Gavorrano in provincia di Grosseto, nel 1932 ci fu infatti una ribellione di minatori, con assalto agli uffici della dirigenza e distruzione delle macchine che misuravano il Bedeux. In conseguenza della rivolta quel sistema di cottimo fu sospeso e le autorità fasciste del luogo non poterono far altro che accettare il fatto compiuto.
Lo sfruttamento della manodopera è del resto un aspetto costante in tutta la storia dell’Arsa, entrata a far parte nel 1919 di una società italiana che la acquisisce perché pensa di poter trovare opportunità di affari producendo un combustibile fossile di cui l’Italia è povera. Si tratta però di un prodotto che non può reggere il confronto con il carbone del Centro-Europa, dell’Inghilterra, della Russia e perfino degli Stati Uniti: inferiore è il suo potere calorico, costosa ne risulta la ricerca e l’estrazione. La sorte del carbone italiano (la lignite dell’Arsa, come la lignite del Sulcis e la lignite della Maremma) è quindi strettamente legata all’andamento dell’economia mondiale, destinata ad essere valorizzata soltanto quando i mercati internazionali si chiudono, come nell’epoca delle sanzioni economiche e poi ancora al tempo della guerra.
Quindi si può dire che una prima fase nella storia dell’Arsa, quella che va dal 1919 fino al 1935, è connotata dalla provvisorietà economica. In realtà non mancarono investimenti di un certo impegno: la modernizzazione più ampia fu realizzata tra il 1925 e il 1928, quando fu introdotta l’elettrificazione dei servizi e dei macchinari per l’estrazione, ma l’atteggiamento del governo italiano fu sempre incerto e talvolta quasi restio a concedere le agevolazioni che venivano richieste dalla proprietà. Quando il governo assunse dei provvedimenti, lo fece in forma episodica e frammentaria. Se da una parte non si sapeva come collocare il prodotto, dall’altra pareva tuttavia necessario compiere qualche forma di intervento che potesse risollevare la depressa economia istriana. Non posso addentrarmi di più nei particolari, ma mi pare che si possa dire che questa precarietà si riflette nella vita dei minatori. Ad Albona - che aveva conosciuto nel marzo 1921 l’episodio noto come “Repubblica di Albona” con l’occupazione della miniera e la sua autogestione da parte dei minatori - la lotta sindacale e politica, ed anche la stessa esistenza umana, è particolarmente dura perché incerta e precaria è la sopravvivenza e la continuità del lavoro.
Il dilemma rappresentato dal carbone istriano fu sciolto nel 1935, quando - dopo le sanzioni economiche proclamate dalla Società delle Nazioni contro l’Italia - fu creata l’Acai, una società a capitale misto pubblico e privato, la quale possedeva sia l’Arsa, sia le miniere sarde del Sulcis, nell’ambito di un programma sorto per valorizzare la produzione del carbone italiano. Da qui prende avvio la crescita industriale dell’Arsa. Nel 1935 si producevano 350.000 tonnellate circa con 1839 operai, nel 1936 raddoppiano la produzione e il numero degli addetti, nel 1939 si raggiunge il milione di tonnellate con quasi 9.000 operai. L’Arsa era diventata la più grande miniera d’Italia.
Il carbone che con tanta enfasi la stampa di regime definiva “nazionale”, in realtà non rappresenta alcuna forma di integrazione tra l’economia italiana e l’economia istriana, giacché esso, una volta estratto, veniva caricato nei porti di Stallie e Valdivagna e spedito via mare verso altre destinazioni: si tratta quindi un caso di sfruttamento della materia prima giacente in loco, più che di un investimento capace di ricadute ampie su scala locale, anche se non si può negare che per Albona e l’Albonese la miniera rappresentasse in quegli anni un’importante fonte di lavoro.
Per intensificare i risultati vennero costruiti in fretta e con ritmo assai sostenuto nuove discenderie, nuove gallerie a mezza costa e a carreggio, nuove gallerie secondarie e nuovi cantieri di coltivazione. I cantieri si rinnovavano continuamente, via via che il giacimento veniva esaurito. Non risulta con certezza se all’Arsa la ripiena del materiale scavato fosse eseguita con materiale sterile, come suggerito dalle regole dell’arte mineraria, ma - da quanto possiamo ricavare da incidenti analoghi accaduti altrove - questa era in effetti una delle norme più disattese. Sicuramente (lo dice il distretto minerario nella sua relazione sul disastro del 1940) la ventilazione era imperfetta, il flusso d’aria non aveva il discendente continuo, l’aria di afflusso di mescolava con quella di riflusso, mentre le vie destinate all’entrata e all’uscita dell’aria avrebbero dovuto essere divise da un sufficiente spessore di roccia per resistere all’eventuale esplosione. I gas di accumulo possono aver facilitato l’autocombustione, possiamo supporre lo scoppio innescato da una scintilla fuoruscita da una lampada difettosa, oppure da una mina usata per abbattere il minerale oppure ancora da una perforatrice meccanica. L’incendio - evento non raro purtroppo in una miniera di lignite - può aver trovato facile esca nelle armature di legno, la cui sostituzione con armature in metallo - lo sappiamo da una rara testimonianza d’epoca riportata nell’opuscolo a cura del Circolo Istria - era stata rifiutata dalla direzione. L’onda esplosiva si propaga seguendo il riflusso dell’aria; chi non muore ustionato o non cade sotto il franamento della galleria, muore per asfissia a causa dell’ossido di carbonio che si propaga nei cantieri laterali.
Alle ore 4.45 del 28 febbraio 1940 esplose la cosiddetta “camera 1” della miniera. Le fonti di cui disponiamo, importanti per ricostruire il contesto generale in cui avvenne l’incidente, poco in realtà ci dicono della sostanza vera, del contenuto di umana sofferenza di quella catastrofe.
“Le mogli e i figli dei minatori piangevano ed emettevano grida che si udivano a distanza di oltre un chilometro”: è uno dei pochi ricordi diretti che ci siano rimasti (lo si può trovare nel citato opuscolo del Circolo Istria). Non sappiamo come l’incidente si sia manifestato al’esterno. Un boato? un’eplosione ? Una nube fu vista uscire dal pozzo? Possiamo solo immaginare l’angoscia di chi attendeva notizie e la disperazione di chi era raggiunto dalla certezza di aver perduto un congiunto. Possiamo solo immaginare l’estrazione dei poveri corpi, avvolti in coperte militari o in lenzuola, deposti l’uno accanto all’altro in una qualche sala del paese trasformata in camera ardente. Le operazioni di raccolta delle vittime richiesero più giorni per la difficoltà del reperimento e si protrassero fino al 12 marzo. Nel frattempo si erano celebrati i funerali che, per l’alto numero delle vittime, si erano svolti in più riprese, prolungando la strazio e il lutto della collettività coinvolta, concentrata per lo più nell’Albonese, ma estesa anche ad altre località dell’Istria e perfino d’Italia.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
A. Millo, A. Maria Vinci, Azienda, sindacato e classe operaia nelle miniere dell'Arsa, in Silva Bon Gherardi (et al.),L'Istria tra le due guerre. Contributi per una storia sociale, Ediesse, Roma 1985.
Arsia 28 febbraio 1940, Circolo di cultura istro-veneta «Istria», Trieste 2007.
.L. Bianciardi, C. Cassola, I minatori della Maremma, Laterza, Bari 1956.