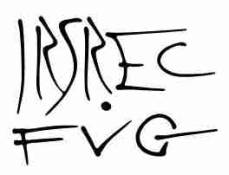R. Pupo, Foibe ed esodo: un'eredità del fascismo?
Scritto da Super User
Foibe ed esodo: un'eredità del fascismo?
di Raoul Pupo
Il problema
Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati come eredità del fascismo e della guerra: è questo un modo assai diffuso di leggere due fra le più gravi tragedie che hanno colpito gli italiani della Venezia Giulia alla metà del secolo scorso, ma che in sé contiene non poche ambiguità. La proposizione infatti si presta a venir interpretata con sfumature assai diverse: dall’ineccepibile intento di contestualizzare fenomeni altrimenti inesplicabili nelle loro logiche, al meno encomiabile desiderio di relativizzare la gravità dell’accaduto presentandolo come mera conseguenza – in qualche misura inevitabile – delle precedenti stagioni di sopraffazione nazionale e politica. Al riguardo dunque, sarà opportuna qualche precisazione.
Non c’è dubbio infatti che quella del «fascismo di frontiera» sia stata una semina di violenza e di sangue, che il secondo conflitto mondiale ha poi moltiplicato e dilatato su di un’area più vasta, al di là dei confini di Rapallo, attraverso il meccanismo della guerra di aggressione, delle occupazioni e delle annessioni. È stata una semina di violenza che ha generato un’abitudine alla violenza, esasperata dalle esperienze limite vissute dalla società di frontiera nel periodo in cui l’area giuliana fu parte della Zona di operazioni Litorale Adriatico; ed anche il raccolto, dunque, non poteva essere che di violenza e di sangue. Si tratta di una conclusione abbastanza scontata, strano sarebbe stato se mai il contrario. Sul piano del giudizio storico però, il problema che si presenta è quello di capire se le foibe e l’esodo rappresentano veramente e soltanto la conclusione dei processi storici precedenti, e se, in ogni caso, possono venir considerate solamente il lascito di morte che il fascismo e la sua guerra hanno trasmesso al dopoguerra.
La risposta credo debba essere articolata. Le stragi compiute nella Venezia Giulia dal movimento partigiano sloveno e croato e dagli organi dello Stato jugoslavo nel 1943 e nel 1945, correntemente – anche se in maniera imprecisa – conosciute come «foibe», costituiscono certamente uno dei picchi delle violenze registratesi nell’area alto adriatica nella prima metà del secolo, ma non certo l’unico e nemmeno particolarmente fuori scala rispetto ad altri eventi luttuosi che coinvolsero la popolazione civile. Anche senza pensare ai bombardamenti aerei, pensiamo alle migliaia di vittime dell’offensiva tedesca in Istria nell’autunno del 1943, ovvero alle altre migliaia di uccisi nella Risiera di San Sabba. Senza imbarcarsi in assurde gerarchie del dolore, possiamo limitarci a notare che siamo in presenza di tragedie più o meno dello stesso ordine di grandezza. Inoltre, l’impatto delle foibe fu enorme, all’epoca e poi ancora per decenni, fino ad oggi, sul piano delle tragedie individuali e familiari, sul piano psicologico e su quello politico, ma non si è trattato certo di un fenomeno conclusivo: non si può dire cioè che abbia alterato sostanzialmente gli equilibri tra i gruppi nazionali viventi nella regione giulia.
Quanto all’esodo invece, esso appare effettivamente come la conclusione della crisi che si era aperta non con il fascismo, ma nel 1918 – quando la sostituzione dell’Impero asburgico con gli stati nazionali italiano e degli slavi del sud innescò una serie di spostamenti di popolazione di grandi dimensione – ma che, a dire il vero, era stata preannunciata già nei decenni precedenti al finis Austriae, con l’affermarsi dei nazionalismi di massa e della conseguente volontà di possesso esclusivo dei territori da parte dei diversi gruppi nazionali. L’esodo quindi fissò un nuovo assetto stabile degli equilibri nazionali nell’area giuliana, e fu certo conseguenza diretta della guerra perduta, con la quale il fascismo disperse dopo poco più di un ventennio i frutti della grande guerra. Tuttavia, se una qualche punizione territoriale risultava piuttosto ovvia, dal momento che era stata l’Italia ad aggredire la Jugoslavia, la completa scomparsa della presenza italiana dai territori ceduti era molto meno scontata.
Consequenzialità degli avvenimenti ed autonomia dei progetti e delle forme di lotta sono dunque i due poli che fissano le coordinate al nostro ragionamento storico. Cominciamo quindi con il vedere sinteticamente quali sono i connotati essenziali dei due fenomeni di cui ci occupiamo – foibe ed esodo – e poi vedremo come interagiscono con quelli precedenti.
Le stragi delle «foibe»
Per «foibe» intendiamo qui sinteticamente le violenze di massa, a danno principalmente – ma non esclusivamente – di italiani, avvenute in due ondate, nell’autunno del 1943 e nella primavera del 1945; e ciò a prescindere dalle modalità con cui avvennero le uccisioni e le inumazioni. Naturalmente, questo non è l’unico significato possibile del termine, ma è quello che in sede di ricostruzione storica ci consente di cogliere le specificità del fenomeno. Il significato letterale infatti, indica una tecnica di assassinio di massa, non esclusiva dell’area giuliana, e riguarda solo una parte delle vittime delle due ondate, e soprattutto della seconda. Specularmente, il significato estensivo che viene frequentemente adottato nel linguaggio politico italiano – non più solo di destra – e che copre tutte le vittime italiane cadute per mano del movimento di liberazione sloveno e croato nell’area giuliana dal 1943 in poi, ha una valenza ideologica e non storica, e impedisce di comprendere la specificità dei fenomeni verificatisi nei due momenti di violenze di massa.
Quanto ai criteri di lettura di quegli avvenimenti, il punto di partenza rimane le distinzione proposta ancora alla fine degli anni Ottanta da Elio Apih, fra «scenario» e «sostanza politica» delle stragi[1]. Dove per scenario si intende il clima di «furore popolare» e di «resa dei conti», che è ben visibile in entrambe le fasi: con maggior evidenza nell’autunno del 1943 e comunque nel contesto istriano, ma in ogni caso con sufficiente chiarezza anche nella primavera del 1945 e nelle aree urbane di Trieste e Gorizia. Da questo punto di vista, gli episodi cruenti e le vendette perpetrate a danno di fascisti e collaborazionisti dei tedeschi, non differiscono sostanzialmente da tante altre vicende dei dopoguerra europei, nelle fasi cruciali del crollo del potere nazifascista: fu un crollo però che nella regione giulia avvenne non una ma due volte, dopo l’armistizio dell’Italia e dopo la cacciata dei tedeschi, e duplice quindi fu anche l’esplosione di violenza. Naturalmente, nel caso giuliano agli antagonismi politici si saldarono quelli nazionali, perché l’oppressione aveva avuto entrambi i caratteri, ed anche perché all’interno del movimento di liberazione sloveno e croato l’animus nazionalista era assai forte: in alcune circostanze quindi si ebbero scoppi di furore nazionale che travolsero ogni argine. Nello stesso quadro di deragliamento della violenza, rientrano i casi, tutt’altro che infrequenti, di errori, eccessi, commistione di rappresaglie politiche e personali, inserimento della criminalità comune e così via.
Tutto ciò, peraltro, rappresenta ancora soltanto il quadro, il clima politico e psicologico entro il quale maturarono le stragi, e di per sé non è sufficiente a spiegare dimensioni e valenza del fenomeno. La sostanza del dramma, come diceva Apih, è riconducibile invece ad una progettualità politica, che ha lasciato tracce evidenti. Sono tracce meno clamorose nel 1943, vista la grande confusione della realtà istriana del tempo, ma ugualmente chiare nelle fonti, che parlano in maniera esplicita di una repressione pianificata – anche se poi realizzata un po’ alla carlona – dei «nemici del popolo»[2]. È questa – com’è noto – una categoria estensibile a piacere e che nel concreto della situazione jugoslava del tempo indicava tutti gli avversari, reali o anche soltanto potenziali, dal punto di vista politico e di classe, del movimento di liberazione. Il riferimento alla prassi normalmente seguita dal movimento di liberazione jugoslavo nel corso della sua lotta contro tedeschi, italiani, collaborazionisti e concorrenti ci aiuta anche a superare l’impressione di eccezionalità delle foibe istriane, che riproduce la memoria della popolazione italiana della regione, sorpresa da un’imprevista ondata di violenza. Anche altrove infatti, nel corso della sanguinosissima guerra di liberazione - guerra civile jugoslava, il movimento partigiano guidato da Tito aveva accompagnato una capacità di attrazione politica progressivamente crescente rispetto a quella dei gruppi domobranci, ustaša e cetniči, con un’estrema decisione nell’annichilimento dei suoi avversari: in Montenegro, in Bosnia, nell’entroterra dalmato, nel Gorski Kotar, l’eliminazione di intere élites di villaggi non disponibili a passare dalla parte dei partigiani era stata una scelta tutt’altro che inusuale. Da questo punto di vista, si può dire che quelle che gli italiani chiamano «foibe istriane» rappresentano – al di là, s’intende, delle loro valenze specificatamente nazionali – l’estensione alla Venezia Giulia di una modalità di controllo del territorio da parte del movimento di liberazione jugoslavo, altrove già ampiamente collaudata. Ma nel ragionamento si può andare anche oltre: le tecniche stesse dei massacri rinviano direttamente alla guerra civile jugoslava innescata dall’invasione tedesca e italiana e dallo smembramento del paese, posto che fin dall’estate del 1941 le fonti ci parlano ampiamente delle stragi compiute da elementi ustaša a danno della popolazione serba in Bosnia, e nel corso delle quali la pratica dell’infoibamento venne utilizzata su larga scala[3]. A partire dal 1943 dunque, l’Istria entrò a far parte del contesto jugoslavo, e ciò che vi accadde si spiega solo attraverso quelle logiche. Così, ancor prima che Trieste fosse lambita dall’onda della rivoluzione – come ha suggerito Elio Apih a proposito del maggio 1945 – la penisola istriana venne raggiunta dalle estreme propaggini delle guerre balcaniche; e proprio la sua perifericità rispetto all’epicentro della crisi jugoslava fece sì che l’ondata di violenza successiva all’8 settembre, per quanto sconvolgente, si dimensionasse principalmente come una decapitazione di classe dirigente e non come una mattanza indiscriminata – pur in presenza di alcuni episodi assai foschi – o come un tentativo di sterminio etnico.
In ogni caso, ben più palese risulta l’importanza del disegno strategico di annichilimento di ogni forma di possibile contropotere, o anche soltanto di nuclei di dissenzienti, nelle vicende della primavera del 1945 ed in particolare nei centri urbani: Trieste, Gorizia, Fiume. Al riguardo però, e pur nella considerazione dell’unicità del fenomeno, conviene introdurre nell’analisi alcune articolazioni, che evitino un’eccessiva genericità di giudizi, specie per quanto riguarda la particolarità del destino di morte riservato ad un gran numero di italiani.
Ad esempio, sappiamo bene che una parte significativa delle vittime del 1945 fu costituita da militari appartenenti alle forze armate della RSI di stanza nella Venezia Giulia. Il trattamento loro riservato va pertanto confrontato con quello subito nella medesima area e nel medesimo periodo ai combattenti degli altri eserciti dell’Asse presenti in misura assai maggiore sul territorio, e cioè i tedeschi e i reparti domobranci, ustaša e cetniči. Possiamo così notare che la sorte peggiore fu senza dubbio quella incontrata dai prigionieri slavi, per i quali non ci fu scampo: quelli caduti nelle mani dei partigiani vennero fucilati, ma anche quelli che erano riusciti a consegnarsi agli alleati, non per questo trovarono la salvezza[4]. Così accadde ai domobranci che si credevano oramai al sicuro in Carinzia, ma che vennero invece restituiti alle autorità jugoslave. Quel che ne seguì, fu una vera mattanza. I domobranci rimandati in Slovenia da Vetrinje attraverso Podrožca vennero in parte rinchiusi nel castello di Škofja Loka e fucilati in piccoli gruppi nei dintorni; la maggior parte venne condotta al campo di raccolta di Šentvid e da lì nel Kočevski Rog, dove i prigionieri furono uccisi e i loro corpi gettati nelle grotte carsiche. Quanti invece erano rimpatriati attraverso Pliberk (Bleiburg) e Teharje, vennero condotti a Stari Hrastnik, uccisi e gettati nei pozzi minerari della zona. Una fine simile incontrarono anche i militari dello Stato indipendente di Croazia: non si trattava solo di croati, ma anche di appartenenti al corpo dei volontari serbi, di soldati montenegrini e di altre nazionalità ed anche di civili, che si erano spostati assieme alle truppe attraverso la Slovenia per cercar scampo in Carinzia. Il ritorno verso la Croazia dei profughi bloccati prima di Pliberk nella valle della Drava fu accompagnato da innumerevoli esecuzioni – soprattutto dei sostenitori dello Stato indipendente di Croazia e degli ufficiali domobranci – che si sono conficcate nella memoria collettiva croata con il nome di «Bleiburška tragedija» (tragedia di Bleiburg), «Križni put» (Via Crucis) e «Marševi smrti» (La marcia della morte). Il territorio della Slovenia – passaggio obbligato per chi fuggiva e per chi, suo malgrado, tornava dall’Austria – divenne quindi un immenso cimitero: attualmente, sono segnalate almeno 400 sepolture comuni, tra foibe, siti minerari, bunker, fossati anticarro e semplici fosse collettive, ma le ricerche sono ancora in corso. Tutto il sottosuolo, fino alle estreme propaggini del Carso triestino e Goriziano, è punteggiato di tombe in cui giacciono spoglie spesso ancora senza nome, e la tipologia delle inumazioni di massa, come pure quella delle esecuzioni collettive, (le sevizie, il filo di ferro che lega fra loro i prigionieri, le fucilazioni sull’orlo dell’abisso) è del tutto simile alla prassi già sperimentata in Istria, a danno degli italiani, nell’autunno del 1943.
Rispetto al trattamento limite subito dai militari delle formazioni collaborazioniste slave, quello riservato ai soldati italiani e germanici fu intermedio. Nei loro confronti non vennero certo applicate le convenzioni internazionali – che per la verità, nella «guerra totale» combattuta nei Balcani raramente erano state rispettate – ma neanche furono ammazzati tutti. Diverse testimonianze, sia italiane che tedesche, parlano di fucilazioni eseguite nei giorni immediatamente seguenti alla resa, ma il loro numero è difficile da precisare, così come la logica che le ispirò[5]. Per quanto riguarda gli italiani, in alcuni casi ci si trova di fronte ad atti di giustizia sommaria nei confronti di soggetti che si erano distinti nella lotta antipartigiana o che si erano macchiati di colpe nei confronti della popolazione civile. La morte fu anche la sorte che attese chi si proclamava, o veniva ritenuto, fascista convinto, ma in altri casi invece sembra si possa parlare piuttosto di capri espiatori, scelti casualmente fra i prigionieri in base alla logica della «colpa collettiva». Anche i procedimenti giudiziari imbastiti nei primi giorni di maggio, più ancora che un carattere sommario sembrano spesso aver assunto quello di una formalità. Siamo qui in presenza della stessa metodologia repressiva che già era stata applicata in Istria dalle autorità partigiane nell’autunno del 1943, quando il tribunale del popolo insediato a Pisino aveva proceduto ad infliggere con grande larghezza e velocità di giudizio la pena capitale anche ad imputati sul cui capo non gravavano colpe tali da giustificare la morte. Criteri simili vennero applicati anche altrove, nella primavera del 1945: è il caso, ad esempio, dei processi sommari contro i membri della questura di Trieste – tra i quali, presumibilmente, anche alcuni aguzzini dell’Ispettorato speciale per la Venezia Giulia – avvenuti a Basovizza il 2 e il 3 maggio per opera di ufficiali della IV Armata jugoslava ed alla presenza della popolazione del paese, in veste di accusatore collettivo, non sappiamo se spontaneo o debitamente sollecitato[6]. Anche in questa vicenda, conclusasi a quanto pare con un infoibamento di massa, l’andamento dei procedimenti sommari non consente di individuare le responsabilità personali – che talora erano state verosimilmente assai gravi, ma in altri casi forse no – perché il fine del giudizio non era quello di portare alla luce e punire le colpe individuali, ma di colpire con la massima durezza possibile una categoria di persone che riassumeva in sé i tratti distintivi più odiosi del nemico. Ha scritto al riguardo Elio Apih:
Eliminazione fisica dell’oppositore e nemico (di forze armate giudicate collaborazioniste) e, insieme, intimidazione e, col giudizio sommario, coinvolgimento nella formazione violenta di un nuovo potere. Tale pare la logica dei fatti. La spontaneità del furor popolare si cementa in una sorta di patto di palingenesi sociale, attestato e garantito dalla punizione dei colpevoli, che basta individuare anche sommariamente, perché il loro ruolo è simbolico prima che personale[7].
Combattendo contro i partigiani, soldati tedeschi e della Repubblica di Salò avevano dunque già firmato la loro condanna, anche se poi le pene furono variabili. A loro vennero assimilati anche i componenti della Guardia di Finanza e dei carabinieri, che non avevano in genere partecipato ad attività antipartigiane, anzi, in alcuni casi avevano aiutato la resistenza. Il caso più clamoroso è proprio quello dei finanzieri[8]. Come in altre parti d’Italia, a Trieste le unità della finanza erano state largamente infiltrate dal CLN ed avevano svolto un ruolo significativo durante l’insurrezione antitedesca del 30 aprile. Non si tratta di una particolarità locale: a Milano, vista la lontananza delle formazioni partigiane di montagna, i finanzieri sopportarono buona parte del peso delle operazioni contro i tedeschi e il 26 aprile occuparono la prefettura in nome del CVL[9]. La differenza è, che a Milano diventarono eroi, a Trieste vennero infoibati. Per le autorità jugoslave infatti, si trattava pur sempre di militari stranieri, che andavano considerati a tutti gli effetti come truppe occupanti e trattati di conseguenza. Allo stesso modo, gli aderenti alle formazioni partigiane del Corpo Volontari della Libertà politicamente dipendenti dal CLN, che a Trieste erano insorte contro i tedeschi ma non riconoscevano né l’autorità dei comandi dell’armata popolare di liberazione, né – tantomeno – la legittimità delle rivendicazioni territoriali jugoslave, si erano in tal modo qualificati come nemici della nuova Jugoslavia e vennero quindi trattati in blocco come «fomentatori di guerra civile»[10].
Dopo la capitolazione e le esecuzioni sommarie, per i militari giunse il momento del trasferimento nei campi di prigionia. Al riguardo, le testimonianze italiane e tedesche sono concordi: nella maggior parte dei casi il viaggio si trasformò in una «marcia della morte» durante la quale i feriti, gli ammalati, i più deboli o sfortunati vennero abbattuti lungo la strada[11]. Ciò accadde un po’ dovunque nel corso del mese di maggio e quale causa principale dello sfinimento che ben presto colse i deportati, rendendoli incapaci di proseguire e condannandoli di conseguenza a perdere la vita, le fonti convengono nell’indicare le carenze alimentari: concretamente, si moriva di fame, di sete e per la dissenteria causata da cibo avariato ed acqua inquinata. La fame quindi divenne l’inseparabile compagna dei prigionieri durante tutto il periodo della loro detenzione, nelle marce e nei campi: alcuni episodi rivelano certamente trascuratezza e malvagità dei carcerieri – far cuocere la minestra in bidoni di benzina non lavati rasenta il sadismo – ma il fenomeno appare così generalizzato da rimandare a cause anch’esse generali.
Che nella Jugoslavia sconvolta dei primi giorni di pace gli approvvigionamenti fossero problematici, non pare dubbio, così come sono evidenti le difficoltà che i quadri dello Stato nascente incontrarono nel rimettere in funzione un minimo di strutture amministrative: le lamentele sull’impreparazione della dirigenza uscita dall’esperienza partigiana e spesso sopraffatta dalla mole delle questioni da risolvere, compaiono frequenti nelle fonti, non solo italiane. Alcune realtà costituirono un visibile banco di prova, una vera e propria vetrina della capacità del nuovo Stato nel rispondere alle esigenze elementari delle popolazioni che si voleva entrassero a far parte della Jugoslavia: è il caso soprattutto delle città, ed in particolare di Trieste, dove l’amministrazione prima militare e poi civile jugoslava operava davanti agli occhi attenti, e critici, degli anglo-americani. Lo sforzo per rifornire la città fu evidente, ma insufficiente: solo l’arrivo di generi alimentari dal Friuli avrebbe potuto alleviare la penuria, ma le autorità alleate vietarono l’invio oltre Isonzo di generi alimentari, in modo da far meglio risaltare le carenze dell’amministrazione jugoslava. Così, l’arrivo a fine maggio di un’autocolonna di generi di prima necessità inviati dal Vaticano – bianchi camion carichi di trecento tonnellate di farina, mais e olio – costituì una benedizione per i triestini ed un visibile smacco per i «poteri popolari»[12]. Le autorità jugoslave non erano dunque in grado di far fronte all’emergenza alimentare e dirottarono le poche risorse secondo necessità politiche: ma nella scala delle priorità, la sopravvivenza delle decine di migliaia di prigionieri di guerra caduti nelle mani dell’esercito popolare di liberazione si trovava certamente all’ultimo posto. In molti casi ciò significò la morte[13].
Quanto ai civili invece, il loro arresto avvenne in genere sulla base delle indicazioni fornite sul momento dagli stessi quadri partigiani, delle segnalazioni provenienti da organi di partito e, soprattutto, della gran messe di informazioni raccolta nei mesi precedenti per opera principalmente dell’OZNA. È evidente che le notizie così raccolte potevano essere influenzate da una molteplicità di fattori, fra i quali trovavano posto anche quelli personali, e nella loro frequente genericità ed approssimazione non distinguevano spesso la gravità delle colpe. Ciò però ha poca importanza ai fini della repressione: quello che contava, era che un gran numero di elementi realmente o potenzialmente ostili agli slavi, al movimento partigiano, ai poteri popolari, al comunismo e all’annessione alla Jugoslavia, venissero posti fuori gioco. La ricerca poi delle singole responsabilità appare del tutto secondaria: accadde così che al muro finirono squadristi distintisi fin dagli anni Venti per le loro violenze a Trieste e in Istria, o delatori per conto dei tedeschi – non va dimenticato che nel capoluogo giuliano le autorità naziste erano state letteralmente sommerse di denunce contro ebrei e cospiratori antifascisti[14] – o torturatori della «banda Collotti», ma accadde anche che noti ufficiali della milizia territoriale, con all’attivo numerosi rastrellamenti nella penisola istriana, non venissero riconosciuti e perciò fossero liberati dopo un periodo di detenzione, mentre – solo per fare un esempio – un giovane triestino arrestato per un cenno di saluto rivoltogli da un conoscente appena caduto nelle mani di una pattuglia jugoslava, si fece sei mesi di detenzione nei campi di prigionia jugoslavi, da Borovnica fino al confine rumeno[15].
Ecco dunque emergere piuttosto bene gli elementi portanti del progetto repressivo, non solo ipotizzabili partendo dall’analisi dei comportamenti concreti delle autorità di occupazione jugoslave, ma anche verificabili sulla scorta di una documentazione che – quantomeno per la parte slovena – è molto ricca e significativa[16]. In primo luogo la repressione per categorie, come ad esempio gli uomini in armi, che vennero trattati tutti allo stesso modo – tedeschi, soldati della RSI, combattenti del CVL o anche del CIL rientrati fortunosamente a Trieste – perché l’unica discriminante era quella di essere o meno agli ordini del comando di città dell’Esercito popolare di liberazione jugoslavo. Chi non rispondeva a quegli ordini era un nemico, e se sosteneva di non esserlo, cioè affermava di essere un antifascista, era ancora peggio, perché veniva considerato un fomentatore di guerra civile, che andava «smascherato» ed eliminato. In questi ultimi casi – che fortunatamente non furono molti, perché non bisogna credere che nelle foibe ci siano soprattutto gli antifascisti – vediamo senza ombra di dubbio un movimento resistenziale che ne divora un altro. Altre categorie/bersaglio sono piuttosto ovvie – i componenti l’apparato di polizia, i rappresentanti dello Stato italiano e fascista – altre ancora invece appaiono un po’ meno scontate, almeno dal punto di vista dell’antifascismo italiano: ad esempio, gli autonomisti fiumani, che vennero colpiti subito e con grande durezza, proprio perché possedevano un’indubbia legittimità antifascista, che avrebbe potuto mettere in discussione la pretesa di monopolio dell’antifascismo, che era tipica del fronte di liberazione sloveno e di quello croato.
Ci sono poi altri aspetti significativi da tenere in conto, come la repressione sulla base del semplice sospetto e la larga indifferenza per la verifica delle accuse, che rinviano ad un modello d’intervento di matrice staliniana ben presente nell’operato dei poteri popolari, ed ancor più nella prassi degli organi di sicurezza di quello che oramai era il nuovo Stato jugoslavo. Comunque, più che insistere sui dettagli, conviene qui sottolineare come nel loro insieme tutti gli elementi rimandino ad alcuni criteri generali di intervento, la cui comprensione costituisce il nodo centrale sul piano del giudizio storico.
Elio Apih parlava di «epurazione preventiva» della società giuliana, altri di «presa del potere comunista»[17]: sono tutti modi per dire la stessa cosa. Nella Venezia Giulia non vi fu soltanto un’occupazione militare, che trovava più o meno consenzienti parti diverse della popolazione, ma – portata dalle baionette jugoslave – era in corso una rivoluzione, che si affermava con i modi propri delle rivoluzioni, e cioè con il bagno di sangue. Fu soprattutto – anche se non esclusivamente – sangue italiano, non solo perché italiana era circa la metà della popolazione della regione e la grande maggioranza dei centri urbani, che rappresentavano il fulcro della lotta per il potere, ma perché all’interno della componente italiana era largamente diffusa l’ostilità verso il progetto politico di cui i nuovi poteri erano i portatori: e cioè, l’annessione del territorio alla Jugoslavia socialista. Viceversa, tra la popolazione slovena e croata, la prospettiva dell’annessione del Litorale e dell’Istria alla Jugoslavia fece in genere passare in secondo piano le perplessità, o addirittura le contrarietà, che in altre parti della Slovenia e della Croazia erano piuttosto frequenti, nei confronti del movimento di liberazione a guida comunista e del regime di stampo stalinista che si stava formando[18].
Questo ragionamento ci porta all’acquisizione storiografica forse più importante degli ultimi anni, secondo la quale il fenomeno delle foibe non è pienamente comprensibile se si rimane all’interno delle logiche che muovono la storia italiana del tempo. Bisogna cambiare storia, perché quella che ha coperto l’intera frontiera orientale italiana nelle fasi finali del conflitto è stata la storia della Jugoslavia e del suo movimento partigiano, impegnato in una lotta che era ad un tempo guerra di liberazione ed affermazione nazionale, guerra civile e rivoluzione. Sono quindi le categorie forgiate in quella lotta che trovarono applicazione anche nella Venezia Giulia: una concezione dell’antifascismo che rimandava ad un contesto strategico radicalmente diverso, vale a dire alla prospettiva di uno scontro a breve distanza con il fronte «imperialista», secondo una lettura delle relazioni Est-Ovest che anticipava largamente il clima della guerra fredda e le stesse scelte della politica estera sovietica[19]. Ancora, una visione del ruolo egemonico del Partito comunista sul movimento resistenziale, che non ammetteva alcun altro centro autonomo di produzione di scelte politiche. Conseguentemente, una divisione manichea dei soggetti politici, tra «i nostri» e gli altri, che divenne il criterio guida per il lancio delle politiche repressive, dirette a sbaragliare i nemici del passato – gli occupatori, i nemici del presente, gli oppositori del movimento di liberazione – ed anche i nemici del futuro, cioè i soggetti che si sarebbero potuti rivelare pericolosi per il consolidamento del nuovo ordine. Nella Venezia Giulia naturalmente, questo nuovo ordine presentava due facce, tra loro inscindibili: la costruzione del regime e l’annessione alla Jugoslavia, e questa duplicità moltiplicò dissenzienti e bersagli. Infine, un uso larghissimo della violenza di massa come strumento di elezione per la conquista e il rafforzamento del potere, che condusse alla liquidazione fisica e su larga scala degli avversari: le stragi della Venezia Giulia possono sembrare un unicum nella storia italiana di quei mesi, ma non certo in quella della Jugoslavia, che conobbe massacri anche maggiori.
Conclusivamente, la tragedia delle foibe appare prevalentemente come un fenomeno di violenza dall’alto, che – perlomeno nei suoi intendimenti strategici, perché poi a livello di quadri, i piani facilmente si sovrapposero – non aveva come obiettivo la «pulizia etnica» della Venezia Giulia dagli italiani, come spesso viene detto – confondendo fra l’altro con una certa disinvoltura etnia e nazione – ma in primo luogo l’eliminazione di ogni ostacolo sulla via della costruzione del nuovo potere jugoslavo e comunista, e – in secondo luogo – anche l’intimidazione generale del gruppo nazionale italiano, non già per forzarlo ad abbandonare il territorio – perché ciò non atteneva alle finalità della politica jugoslava nella primavera del 1945 – bensì per mostrare l’inutilità e la pericolosità di qualsiasi forma di opposizione all’annessione.
L’esodo dei giuliano-dalmati
Venendo all’esodo, la prima cosa da dire è che rispetto alle foibe si trattò di un fenomeno indubbiamente meno cruento, ma di dimensioni incomparabilmente maggiori: al di là delle discussioni abbastanza sterili sulle cifre, quando si ragiona come minimo di un quarto di milione di persone, più o meno la metà degli abitanti dei territori interessati, è chiaro che si tratta di un fenomeno quantitativamente importante[20]. Fu un fenomeno lungo, perché durò oltre dieci anni, concentrato dal 1944 al 1956, ma con alcune partenze prima e dopo tali date. Fu un fenomeno periodizzante – e questo è il suo aspetto più significativo – perché la scomparsa quasi integrale del gruppo nazionale italiano da alcune delle sue regioni di insediamento storico, rappresentò una frattura epocale per l’area alto adriatica, spezzando una continuità che durava dall’epoca della romanizzazione. Per tutte queste ragioni, e per altre ancora, l’esodo è ancor oggi un fenomeno largamente da studiare, sia sul versante della storia politica, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi decisionali jugoslavi, sia e molto abbondantemente, sul versante della storia sociale. Dal punto di vista storiografico quindi, quello dell’esodo è un cantiere aperto, molto più di quanto non lo sia la tragedia delle foibe, dove oramai la dimensione prevalente della ricerca è quella della pietà, cioè del dare risposta per quanto sarà possibile dopo mezzo secolo, alle tante domande dei familiari degli scomparsi.
Anche nel caso dell’esodo comunque, possiamo individuare abbastanza rapidamente i suoi tratti cruciali, anche se bisogna dire che su di alcuni nodi lo stato delle fonti non ci consente risposte certe, ma solo ipotesi da verificare.
La prima caratteristica importante da sottolineare, è che si trattò di un esodo totale: non di tutta la popolazione residente nell’area – e cioè i territori già facenti parte del Regno d’Italia e a diverso titolo passati sotto il controllo jugoslavo – ma di un’intera componente nazionale, quella italiana. Quando si parla dell’allontanamento dell’ 85-90% degli italiani, vuol dire che a prendere la via dell’esilio fu un gruppo nazionale al completo delle sue articolazioni sociali, cui si aggregarono anche nuclei di popolazione slovena e croata la cui dimensione è difficile da definire[21].
Fu un esodo a tappe, i cui picchi si dispongono a seguito dei due momenti in cui venne decisa la sorte della Venezia Giulia, vale a dire il trattato di pace e il memorandum d’intesa. Il significato di una scansione del genere è abbastanza trasparente. Al di là dello stillicidio continuo di fughe individuali, e di casi anomali come quello di Zara[22], ciò che mosse le decisioni collettive di esodare, che riguardarono intere comunità – paesi o addirittura città – non fu l’instaurazione del potere jugoslavo, ma la consapevolezza che tale potere era divenuto definitivo. Fino a quando rimase una speranza di cambiamento, la popolazione italiana in genere resistette sulla sua terra, nonostante l’oppressione cui veniva sottoposta fosse stata fin dall’inizio assai dura. Nel caso della zona B del mai costituito TLT, questa speranza rimase viva addirittura fino all’autunno del 1953, e quindi il «grande esodo» cominciò solo successivamente. Viceversa, ogniqualvolta le comunità italiane si resero conto che la dominazione jugoslava non sarebbe venuta meno, nulla riuscì a trattenerle. Così, le perplessità di De Gasperi e la mancanza di strutture per ospitarli ed anche solo per trasportarli in Italia, non scalfirono la volontà dei polesani di abbandonare Pola prima dell’entrata in vigore del trattato di pace, tant’è che l’esodo partì nel pieno dell’inverno del 1946. Le mille angherie cui le autorità jugoslave sottoposero gli istriani che avevano optato per la cittadinanza italiana dopo il 1947, riuscirono solo a ritardare di qualche anno il flusso delle partenze. Gli ultimi dubbi delle autorità italiane alla fine del 1953 sull’opportunità di svuotare la zona B, spinsero i rappresentanti istriani a chiarire che ritardi nella predisposizione dell’accoglienza non avrebbero fermato l’esodo, ma avrebbero soltanto gettato nella disperazione gli italiani che oramai avevano deciso di andarsene.
Si trattò quindi di decisioni inarrestabili, ma resta da chiedersi come vadano intese, se come frutto di libere scelte ovvero di una pressione espulsiva irresistibile? Qui siamo di fronte a quello che costituisce probabilmente il nodo interpretativo di fondo dell’intera vicenda dell’esodo. È un nodo che non può venir risolto rimanendo sul piano formale, perché è ben vero che contro gli italiani non venne mai messa in opera una legislazione di tipo espulsivo, come accadde invece per i tedeschi, nella stessa Jugoslavia ed in altri paesi europei; ma è vero anche che il meccanismo delle opzioni faceva sì che per provocare l’allontanamento in massa del gruppo nazionale italiano risultassero sufficienti le pressioni ambientali, e che esse ci siano state, e ben massicce, ce lo conferma un’infinità di testimonianze.
Tutto questo però non basta ancora per affermare che l’esodo sia stato frutto di un disegno preordinato di espulsione della componente italiana da parte delle autorità jugoslave. Al di là degli indizi contraddittori, per sostenere una tesi del genere dovremmo poter ricostruire il processo decisionale jugoslavo, ma questo oggi non siamo in grado di farlo, anche se le più recenti ricerche si stanno muovendo in questa direzione[23]. Per superare l’impasse, negli ultimi anni si è fatto strada un approccio diverso, potremmo dire di tipo funzionalista, che sposta il discorso dal piano delle intenzioni recondite, a ciò che venne detto e a ciò che venne fatto, scoprendo in tal modo che quanto che emerge è già sufficiente per delineare una progettualità capace di condurre all’esodo, anche se attraverso un’evoluzione che non necessariamente poteva venir prevista a priori[24].
Il nucleo dell’analisi è costituito dallo studio della politica della cosiddetta «fratellanza italo-jugoslava», delle sue ragioni, dei suoi limiti e del suo fallimento. La prima osservazione da fare, al riguardo, è che quella politica venne elaborata nella seconda metà del 1944, in riferimento ad un gruppo nazionale italiano completamente diverso da quello cui fu poi realmente applicata: e questo perché alla fine del 1944 la prospettiva jugoslava era quella di annettere tutta la Venezia Giulia, vale a dire, anche Trieste e Monfalcone, con le loro grandi concentrazioni di classe operaia. In questo caso, quello italiano sarebbe stato un gruppo nazionale assai numeroso, con un profilo sociale estremamente interessante per un paese come la Jugoslavia – che stava vivendo una rivoluzione bolscevica, ma che di classe operaia ne aveva assai poca – e con attitudini politiche abbastanza favorevoli, perché la classe operaia, anche di lingua italiana, si stava orientando in favore dell’annessione alla Jugoslavia, in quanto patria socialista, piuttosto che alla permanenza in Italia, dove appariva assai difficile che il socialismo potesse affermarsi nel dopoguerra.
Quanto ai contenuti della «fratellanza», si trattava di una politica fortemente selettiva: una politica cioè, che non si faceva illusioni sull’atteggiamento delle borghesie urbane portatrici dell’idea nazionale italiana, ed era pronta a trattarle con grande rudezza, ma che credeva invece di poter isolare alcuni nuclei consistenti di popolazione e di classe dirigente italiana, disponibili non solo all’annessione, ma anche a vivere tutte le trasformazioni necessarie per adeguarsi alla nuova realtà istituzionale, sociale e politica. Possiamo dire quindi, che si trattava di una politica in cui fin dal primo momento erano impliciti un ridimensionamento ed una forte trasformazione del gruppo nazionale italiano, ma non necessariamente la sua completa sparizione.
Allo stesso problema possiamo guardare anche in termini diversi: mentre i tedeschi nel dopoguerra vennero tutti espulsi, agli italiani venne offerta invece una seconda opportunità, ma solo nella misura in cui si mostravano disponibili a fare proprio fino in fondo il modello di rapporti nazionali, sociali e politici proposto dal regime. Ciò significava, fra l’altro, rifiutare l’esperienza storica dello Stato unitario italiano, culminata necessariamente con il fascismo; significava considerare come peggior nemico l’Italia del tempo, capitalista e revanscista; e infine significava anche combattere i nemici della Jugoslavia, a cominciare dagli stessi italiani che non ne volevano sapere. Si trattava evidentemente di pretese piuttosto elevate, ma la possibilità che venissero accolte da alcuni segmenti della società locale di lingua italiana non era campata per aria, e per realizzarla venne condotta nei confronti degli italiani un’intensa campagna di mobilitazione, che difficilmente si spiega all’interno di un progetto organico di «pulizia etnica».
Le cose andarono però in maniera abbastanza diversa: Trieste e Monfalcone non vennero annesse e di conseguenza, il gruppo nazionale italiano in Jugoslavia risultò più piccolo e composto soprattutto di ceti urbani e contadini, che si confermarono assolutamente ostili, sia all’inglobamento nello Stato jugoslavo che al comunismo, mentre soltanto qualche nucleo operaio si mostrò inizialmente favorevole al nuovo ordine.
Verso chi non ci stava, le autorità popolari applicarono immediatamente una politica molto dura, che concedeva solo due possibilità: o piegarsi, o andarsene. Quanto invece alla classe operaia, soprattutto a Fiume e Pola, l’impatto con la realtà del regime si rivelò assolutamente traumatico. Valga per tutti un episodio emblematico: nell’autunno del 1945 i maggiori esponenti comunisti italiani di Pirano spedirono a Togliatti una lettera clandestina, in cui denunciavano il nazionalismo slavo e chiedevano l’autorizzazione a ri-costituire il «CLN cospirativo»[25]. Oltre a questo, potremmo citare molti altri episodi, tant’è che fra il 1946 e il 1947 la politica della «fratellanza» appariva già in crisi, e a confermarlo sta il fatto che da Pola e da Fiume gli operai alla fin fine partirono per l’esilio come tutti gli altri italiani. Di conseguenza, quando nel 1948 subentrò anche la rottura con il Cominform, che schierò i comunisti italiani per Stalin contro Tito – e quindi li candidò ai campi di rieducazione dell’Isola Calva – la crisi non costituì tanto una svolta, come ha talvolta sostenuto parte della storiografia italiana, quanto piuttosto la pietra tombale di una politica ormai fallita.
A questo punto – alla fine del 1948 – le città maggiori erano già vuote e la popolazione dei territori ceduti aveva optato in blocco per l’Italia. Ciò significa però che la penisola istriana si trovava in procinto di perdere da un momento all’altro almeno la metà della popolazione, e tutte le competenze professionali superiori, prefigurando quindi un disastro economico suscettibile di innescare una reazione a catena, capace di spingere all’esodo anche chi non aveva motivazioni nazionali per farlo. È questo probabilmente il motivo principale per cui le autorità jugoslave tentarono a modo loro di frenare l’esodo.
Ci potrebbe essere però anche un’altra ragione. La dimensione assunta dalle opzioni gettava completamente all’aria uno degli assunti fondamentali non solo della propaganda, ma anche della cultura politica jugoslava, di stampo esplicitamente etnicista: e cioè la convinzione, che la maggior parte dell’italianità istriana fosse fittizia, frutto di processi di snazionalizzazione e quindi facilmente riportabile alla sua origine etnica. Invece, a clamorosa smentita di tale previsione, e anche di parte dell’impianto teorico che aveva supportato le rivendicazioni jugoslave alla conferenza della pace, tutti i parlanti italiano, ed anche molti che lo parlavano piuttosto poco, proclamarono, nero su bianco, di essere italiani, al punto di volersene andare. Questo era ritenuto evidentemente intollerabile, tanto intollerabile che poi per cinquant’anni, e in parte ancora oggi, la storiografia anch’essa di stampo etnicista ha continuato ad almanaccare sul problema: ma quanti fra gli esuli erano «realmente» italiani? È questo un quesito che, nei termini schematici in cui viene solitamente posto, è destinato probabilmente a rimanere senza risposta, perché trascura il fatto piuttosto banale – già rilevato da Ernesto Sestan fin dal 1944[26] – che in alcune aree mistilingui dell’Istria interna i processi di nazionalizzazione non avevano ancora coinvolto la generalità della popolazione, e che pertanto l’appartenenza nazionale risultava «non dato di natura ma atto di elezione», fortemente influenzato dalle condizioni politiche del momento. Quando Sestan scrisse queste osservazioni, sotto l’impressione della debacle italiana e ben consapevole del triste ricordo lasciato dall’Italia fascista, era convinto che – nel caso di un plebiscito – i nazionalmente incerti avrebbero finito per votare per la Jugoslavia. Invece, la durezza del regime jugoslavo riuscì là dove la propaganda italiana mai avrebbe potuto arrivare, e le opzioni si trasformarono in una sorta di plebiscito con i piedi, in cui una parte imprevedibilmente elevata della popolazione istriana, al posto della Jugoslavia di Tito scelse l’Italia di De Gasperi.
Qui il nostro ragionamento può anche concludersi, perché – scomparsa con tutta evidenza qualsiasi possibilità che nuclei consistenti di popolazione italiana accettassero di farsi «jugoslavizzare» – le poche decine di migliaia di italiani residuali, quelli della zona B, a partire dai primi anni Cinquanta vennero trattati come un mero ostaggio nei negoziati con l’Italia. Proviamo allora a rovesciare il punto di vista, seguendo non più quello del potere, ma quello delle vittime, vale a dire, delle motivazioni che condussero gli istriani alle decisione di esodare.
Non c’è alcun dubbio, che nella memoria il primo posto è tenuto dalla paura legata ai ricordi delle foibe e rafforzata dal continuo stillicidio di violenze che punteggiò il dopoguerra istriano: una paura che rappresentava l’aspetto più evidente dell’oppressione esercitata da un regime, la cui natura totalitaria impediva anche ogni libera espressione dell’identità nazionale. Non è affatto detto però, che in realtà) la paura sia stata realmente la molla principale dell’esodo: diciamo piuttosto, che essa influì in maniera diretta nei casi degli espatri clandestini combinati per salvare la vita – che non furono certo pochi – ma che soprattutto preparò il terreno in cui maturò la scelta dell’esodo da parte delle comunità.
Più sostanziali quindi ci appaiono altri elementi. Il sovvertimento delle tradizionali gerarchie, che erano ad un tempo nazionali e sociali, e che avevano visto il gruppo italiano storicamente egemone in Istria. Allo stesso modo, pesò il ribaltamento dei rapporti di potere fra città e campagna, che fino a quel momento avevano visto la dipendenza economica, politica e culturale delle aree agricole dai centri urbani, com’è usuale in Italia. Un altro elemento importante, che vale soprattutto per la zona B, dove il processo si trascinò più a lungo, fu la progressiva eliminazione dei punti di riferimento culturali e morali del gruppo nazionale italiano, come gli insegnanti e i sacerdoti. Ancora, il peggioramento delle condizioni di vita degli italiani a seguito delle scelte politiche ed economiche del regime. Infine, dobbiamo tenere presente anche altri aspetti, apparentemente più immateriali, ma non per questo meno importanti: la negazione dei valori tradizionali, l’imposizione di nuovi criteri di misura del lavoro e del prestigio sociale, il sovvertimento di abitudini consolidate da generazioni e l’introduzione di nuove regole di comportamento – nei rapporti sociali come nella gestione della terra – la necessità di servirsi di una nuova lingua, pressoché sconosciuta, e di inserirsi in una cultura, che fino ad allora non era stata nemmeno presa in considerazione come tale. Tutti questi fattori combinati tra loro e sommati ai precedenti, suscitarono una crescente sensazione di estraneità, rispetto ad una realtà che stava cambiando velocemente e nella quale c’era sempre meno posto per gli italiani.
Per descrivere quel tipo di percezione collettiva, la storiografia italiana più recente – e qui il riferimento è soprattutto ai lavori di Gloria Nemec[27] – ha introdotto il concetto di «spaesamento», che è divenuto la chiave interpretativa privilegiata cui far ricorso per comprendere l’atmosfera in cui si trovarono costretti a vivere nel dopoguerra gli istriani di lingua, di cultura e di sentimenti italiani. Istriani che – anche quando resistettero più a lungo alle ondate repressive ed alle pressioni politiche del regime – finirono per sentirsi «stranieri in patria»: questa è l’espressione che ricorre più frequentemente nelle fonti della memoria; e si trattava evidentemente di una condizione lacerante, che gettava le fondamenta psicologiche per la scelta dell’abbandono del luogo d’origine.
Legando quindi assieme tutti i diversi aspetti di cui abbiamo fatto menzione, vediamo come attraverso diverse vie e con ritmi diversi, le comunità italiane dell’Istria finirono per arrivare tutte alla medesima conclusione: vale a dire, l’impossibilità di mantenere – nelle condizioni offerte dallo Stato jugoslavo – la propria identità nazionale. Dove il termine identità nazionale – e questo bisogna sottolinearlo, perché è fondamentale – va inteso ben oltre la sola dimensione politico-ideologica, ma come complesso di modi di vivere e di sentire, secolarmente sedimentati, che danno significato all’esistenza di una comunità. È solo muovendo da tale conclusione, che ha senso porsi in maniera non astratta il problema dell’effettiva libertà di scelta di cui poterono disporre gli italiani di Fiume e dell’Istria, al di là del riconoscimento formale del diritto di opzione. Il punto infatti, è costituito dalla valutazione delle alternative concrete a disposizione di chi, in una situazione specifica, rilutta a prendere la via dell’esilio, e in questo senso con grande chiarezza si è espresso ancora nel 1967 Theodor Veiter:
La fuga degli italiani secondo il moderno diritto dei profughi è da considerare un’espulsione di massa. È vero che tale fuga si configura come un atto apparentemente volontario, ma già l'opzione pressoché completa dei sudtirolesi per il trasferimento nel Reich germanico dopo il 1939 mostra come dietro la volontarietà possa esserci una costrizione assoluta e ineludibile. Colui che, rifiutandosi di optare o non fuggendo dalla propria terra si troverebbe esposto a persecuzioni di natura personale, politica, etnica, religiosa o economica, o verrebbe costretto a vivere in un regime che lo rende senza patria nella propria patria di origine, non compie volontariamente la scelta dell'emigrazione, ma è da considerarsi espulso dal proprio paese[28].
Ovviamente, una lettura del genere è stata accolta con entusiasmo dagli storici italiani, ma dovremmo piuttosto considerarla come un invito ad allargare il campo comparativo, per esplorare meglio vuoi le logiche che possono condurre intere comunità nazionali a compiere scelte traumatiche come quelle dell’esilio, vuoi le categorie utilizzate dagli storici per interpretare tali fenomeni[29].
Prima e dopo
Rimane da considerare un ultima questione: se quelli di cui abbiamo finora parlato sono i tratti essenziali delle foibe e dell’esodo intesi come problemi di interpretazione storica, cerchiamo conclusivamente di vedere in quale rapporto essi stanno con alcuni dei precedenti fenomeni di intolleranza nazionale e politica, in modo da comprendere la loro dipendenza o meno dagli avvenimenti del passato.
Alcuni legami sono piuttosto trasparenti. Le crisi di violenza del 1943 e del 1945 costituirono senza dubbio anche la risposta alle violenze precedenti, quelle legate alla presa del potere fascista, alla politica del regime ed agli orrori delle occupazioni. Nelle due fasi parossistiche delle uccisioni di massa, si chiusero molti conti che si erano aperti nelle fasi precedenti e ci furono anche delle sovrapposizioni terribili: parenti di vittime delle foibe del ’43 divennero durante l’occupazione tedesca persecutori degli assassini dei loro congiunti e del movimento partigiano che li sosteneva, per poi cader vittime essi stessi della seconda ondata di vendette. Un altro filo di continuità piuttosto noto è quello che unisce le persecuzioni fasciste, la conseguente emigrazione politica in Jugoslavia, e la resistenza contro gli italiani: pensiamo ad esempio al ruolo importante giocato dai «rivoluzionari di professione» figli di emigrati, nella costruzione del movimento di liberazione in Istria[30].
Ci sono poi ulteriori connessioni che assumono la forma di veri e propri parallelismi, ma che spesso sono sfuggiti all’attenzione, in parte per distrazione degli storici, ma soprattutto perché sono caduti vittime di una sorta di rigetto ideologico che, soprattutto nel discorso pubblico, porta a ritenere incomparabili i soprusi sofferti dalla parte con cui ci si identifica. Eppure, i parallelismi ci sono, eccome, perché alcuni dei problemi che si posero nei due dopoguerra furono assai simili, e fondamentalmente riconducibili alla resistenza che parte della società locale oppose, in forme molto varie, ai progetti dei poteri che assunsero di volta in volta il controllo del territorio.
Ad esempio, nel 1918 come nel 1945 la priorità assoluta, per l’Italia e per la Jugoslavia, era l’annessione, e ciò comportò che le prime vittime della nuova situazione fossero coloro o che si opponevano attivamente, o che comunque venivano ritenuti capaci di contrastare i progetti annessionisti. Di conseguenza, le prime categorie ad essere colpite dai provvedimenti repressivi furono, tanto per cominciare, le autorità che impersonavano il precedente regime: non solo le autorità dello Stato – il che sarebbe abbastanza ovvio – ma anche le autorità religiose, che di quel regime venivano considerate – a torto o a ragione – essere state espressione e puntello. Nel 1918 – e cioè ben prima dell’erompere dello squadrismo fascista – il vescovo sloveno di Trieste si vide la curia devastata, e l’anno dopo fu costretto a scappare a Lubiana, venendo di conseguenza sostituito con l’ordinario militare italiano[31]. Con maggior tempestività, nel 1945 il vescovo italiano di Gorizia venne quasi immediatamente arrestato dalle autorità jugoslave e poi espulso in Italia[32]. Un secondo gruppo di bersagli venne costituito, in entrambe le fasi, dai militanti dell’idea nazionale sbagliata, che si esprimevano – o anche soltanto che avrebbero potuto esprimersi – contro i progetti annessionisti: in entrambi i casi tali soggetti vennero rapidamente posti in condizione di «non nuocere», anche se in modi piuttosto diversi. Un’ulteriore categoria parallela è rappresentata da quanti occupavano professionalmente ruoli di elevato profilo strategico e quindi di potenziale grande pericolosità: non pensiamo solo alle forze di polizia – il che sarebbe ancora una volta scontato – ma ad esempio ai ferrovieri, che vennero epurati con grande rapidità. E infine, gli intellettuali, razza pericolosissima per antonomasia, e a buon diritto: la coscienza nazionale l’hanno inventata loro, come insegnanti la trasmettono alle giovani generazioni, come giornalisti la diffondono, come portavoce dell’identità nazionale costituiscono i punti di riferimento per le comunità in epoca di crisi. Maestri e sacerdoti della nazionalità sbagliata entrarono quindi istantaneamente, dopo la Prima e dopo la Seconda guerra mondiale, nel mirino delle politiche repressive: di suo, il regime comunista jugoslavo ci mise, non subito ma a partire dal 1947, la persecuzione religiosa generalizzata.
Esistono anche altri parallelismi storicamente rilevanti, che riguardano però non tanto i fatti, quanto la mentalità e i ragionamenti che stavano dietro alle logiche di violenza. Ad esempio, assolutamente comune – ma ovviamente incrociata, a vantaggio dei propri connazionali e a danno degli altri – era la negazione di autoctonia nei confronti degli immigrati recenti. Nel primo dopoguerra erano questi gli slavi immigrati negli ultimi decenni dell’Impero asburgico, soprattutto in concomitanza con la costruzione di grandi infrastrutture ferroviarie, portuali e militari; nel secondo dopoguerra furono i cosiddetti «regnicoli», cioè quanti provenivano da altre parti d’Italia ed erano impiegati soprattutto nella pubblica amministrazione. In entrambi i casi, i nazionalisti delle due parti vedevano in questi soggetti, che erano decine di migliaia, la prova tangibile di progetti di modifica degli assetti etnici «naturali» del territorio, e quindi cominciarono con espungerli dai risultati dei censimenti, per cercare poi di farli allontanare rapidamente dal territorio.
Un altro parallelismo importante riguarda la negazione di legittimità all’espressione pubblica della propria appartenenza nazionale. È una negazione che si è concretata in una normativa molto diversificata nei diversi regimi, ma che si è sostanziata di alcuni atteggiamenti di fondo. Di fronte alla lingua straniera, e nemica, parlata nel luogo sbagliato, scattava sovente il rimprovero: se vuoi parlare slavo – o italiano vent’anni dopo – tornatene a casa tua, perché la casa di chi parla un’altra lingua non può essere la stessa della maggioranza.
Su di un altro piano, pensiamo ai profughi, che sono state fra le vittime più evidenti delle oscillazioni della frontiera in un’epoca di nazionalismi di massa: e non si parla qui solo dei disagi, delle lunghe odissee e delle umiliazioni che sono tipiche della profuganza, in entrambi i dopoguerra, ma ci si vuol riferire anche all’uso politico dei profughi come massa di manovra per la nazionalizzazione di spazi strategici per lo stato. Nel primo dopoguerra, molti profughi sloveni dalla Venezia Giulia si trasferirono a Marburg, appena abbandonata dalla popolazione tedesca, per trasformarla in Maribor, oppure vennero spediti nel Prekmurje ex ungherese, ovvero in Kossovo e Macedonia[33]. Nel secondo dopoguerra molti profughi istriani che avevano trovato rifugio a Trieste, furono insediati in una serie di borghi costruiti appositamente per loro nella striscia di territorio che collega Trieste al resto d’Italia e nella quale non esistevano in precedenza insediamenti italiani[34].
Fili di continuità e parallelismi dunque ci sono, più numerosi di quanto generalmente non si creda, tra i due lunghi dopoguerra giuliani, ma le differenze sono forse ancora più profonde. In primo luogo, troviamo un regime fascista che parlava esplicitamente di «bonifica etnica» degli slavi, e che si impegnò a realizzarla, ma alla fine del fascismo le comunità slovene e croate erano ancora lì, numericamente quasi stabili, anche se impoverite e decapitate della loro classe dirigente. Qualche anno dopo invece, troviamo il regime comunista jugoslavo, la cui politica ufficiale era quella della «fratellanza italo-slava», ma in capo a dieci anni gli italiani sparirono quasi tutti. Questo è un bel problema, dal punto di vista interpretativo, che purtroppo è stato a lungo sprecato dall’approccio politico e ideologico, che riduceva tutto alla domanda: ma allora, qual era il regime peggiore? Ad una domanda del genere non possono che seguire polemiche senza costrutto, ma se invece utilizziamo questa apparente stranezza, come un grimaldello per capir meglio la natura dei processi storici, ci accorgiamo subito di alcune differenze importanti.
In primo luogo, il crescendo della violenza tra il primo e il secondo dopoguerra. Quando abbiamo parlato di eliminazione di elementi ostili, e di epurazione da parte delle autorità italiane a partire dall’autunno del 1918, di solito ci si riferisce ad arresti, internamenti, licenziamenti ed espulsioni; nella primavera del 1945 parliamo invece di uccisioni. Negli anni Venti i fascisti picchiavano, devastavano ed ammazzavano, nel secondo dopoguerra accaddero le stragi. Si badi bene, che non è questione di buona volontà, che non è mai mancata da nessuna parte: piuttosto, possiamo parlare di un diverso uso della violenza di massa, che maturò all’interno dei due regimi totalitari degli anni Trenta, quello nazista e quello stalinista, che esplose poi durante la guerra all’est – che fin da subito fu guerra di sterminio – e che proseguì nel dopoguerra, che nell’Europa centrale e balcanica fu luogo di stragi terribili. E la Venezia Giulia, come abbiamo visto, verso la fine del conflitto era tutta dentro quella storia dell’Europa di sud-est.
La seconda differenza è legata al diverso grado di totalitarismo del fascismo italiano e del comunismo jugoslavo. Al fascismo non faceva certo difetto la disponibilità all’uso della forza, anzi, le strutture dello Stato vennero lanciate nella politica di snazionalizzazione: quello che mancava erano le risorse. Mentre gli elementi estremisti preparavano velleitari piani di insediamento di coloni italiani, di fatto, fuori dalle città non esistevano i mezzi per costruire il tessuto nazionalizzatorio: scuole, asili, ricreatori, case del fascio, e così via.
Mancò anche un’analisi corretta del fenomeno nazionale nei cosiddetti «popoli senza storia»: il pregiudizio culturale fondato sulla superiorità della civiltà latina, impedì di rendersi conto che le identità nazionali, una volta che si sono radicate, non si lasciano più sradicare, a meno di non sradicare anche le persone. Di conseguenza, il tentativo di riavviare a forza il processo di assimilazione degli slavi era destinato a fallire.
Infine, il fascismo era un regime conservatore dal punto di vista sociale, e che quindi non aveva alcun interesse a buttare all’aria le strutture delle società contadina slava. Se mai, al contrario, cercò di ripristinare gli assetti tradizionali, fondati sulla dipendenza degli slavi e il paternalismo degli italiani: ma in questo modo, nelle campagne rimasero larghi spazi per assorbire l’impatto del regime. Al contrario, quello comunista jugoslavo era un regime rivoluzionario, capace di entrare in tutte le pieghe della società e di porre a tutti, individui e comunità, l’alternativa senza scampo: o accettare di venire radicalmente trasformati, o sparire.
A questo punto quindi, possiamo guardare complessivamente alle strategie rivolte verso le minoranze da parte dei due regimi, come a due politiche né ab origine radicalmente espulsive, né – tantomeno – genocide, ma fondamentalmente di integrazione selettiva: una parte della popolazione andava eliminata, l’altra trasformata e quindi assorbita. C’è però una forte asimmetria. Il fascismo mirava a distruggere la classe dirigente slovena e croata, di formazione abbastanza recente, in modo che le masse destrutturate divenissero facile preda del processo di italianizzazione. Il primo passo riuscì, il secondo no, e di conseguenza, sloveni e croati – contrariamente alle intenzioni – non scomparvero. Il regime di Tito fece l’opposto: individuò all’interno della componente italiana una minoranza e – come abbiamo visto – ne fece l’interlocutore della politica della «fratellanza», che prevedeva una forma di integrazione subordinata. Al di fuori di questi italiani «buoni e onesti», rimanevano solo i «residui del fascismo», per i quali però non vi era alcuno spazio nella nuova Jugoslavia.
I punti di partenza quindi erano diversi, e lo svolgersi degli avvenimenti allargò ulteriormente la forbice, perché le condizioni dell’integrazione nella realtà jugoslava risultarono troppo pesanti non solo per gli strati urbani italiani non proletari, che costituivano il nemico storico e di classe del nuovo regime e che erano comunque fuori dalla «fratellanza», ma anche per i gruppi sociali incerti, come i contadini, ed alla fin fine per la stessa classe operaia.
Ecco allora, per concludere il nostro ragionamento, che se noi rinunciamo agli schemi lineari e monocausali di lettura della storia giuliana del Novecento – sia che accettiamo o che respingiamo i loro capisaldi – e li sostituiamo con una rete di relazioni in cui alcuni fili si intrecciano strettamente, ed altri invece si svolgono in maniera autonoma, seguendo le grande passioni del Novecento – gli antagonismi nazionali, le aspirazioni totalitarie, le politiche di potenza – se riusciamo ad entrare con una certa tranquillità in questa dimensione interpretativa, allora diventa molto più facile non tanto «prendere posizione» di fronte alle molte tragedie del Novecento alla nostra frontiera orientale (cosa che dobbiamo comunque fare, come cittadini e come democratici), quanto piuttosto capire il senso di quello che è successo. È proprio questo che agli storici viene giustamente chiesto di provare a spiegare, anche per limitare i danni di un uso politico della storia che privilegi eccessivamente l’esigenza delle opportunità del momento, rispetto a quella della verità.
[1] E. Apih, Trieste, cit., pp. 165-167.
[2] Cfr. Un rapporto del servizio informativo partigiani sui fatti istriani dell’autunno 1943 in R. Pupo, R. Spazzali, Foibe, B. Mondadori, Milano 2003, pp. 58-61.
[3] Cfr. al riguardo P. Cohen, Serbia’s Secret War: Propaganda and the Deceit of History, «Eastern European Studies» n. 2 e O. Talpo, Dalmazia, cit., vol. 1, pp. 405-419.
[4] Molte notizie sugli eccidi avvenuti in Slovenia nell’immediato dopoguerra sono contenute in F. Perme, A. Zitnik, F. Nucic, J. Crnej, Z. Zavladav, Slovenia 1941-1948-1952. Anche noi siamo morti per la patria. I sepolcri tenuti nascosti e le loro vittime: raccolta, Lega nazionale d’Istria Fiume Dalmazia - Mirabili Lembi d’Italia, Milano, s.d, edizione originale Associazione per la sistemazione dei sepolcri tenuti nascosti, Lubiana – Grosuplje 2000; l’eterogeneità del materiale non ne facilita l’utilizzo per fini scientifici. Più sistematica è la ricerca sulle esecuzioni e sulle fosse comuni condotta da Mitja Ferenc, i cui primi risultati sono stati esposti nella mostra Prikrito in očem zakrito. Prikrita grobisca 60 let po koncu svetovne vojne. (Celato e nascosto agli occhi. Sepolture nascoste a 60 anni dalla Seconda guerra mondiale), realizzata dal Museo di storia contemporanea di Celje, e dal cui catalogo è tratta la maggior parte delle informazioni riportate nei seguenti paragrafi. Cfr. anche J. Tomasevich, War and revolution in Yugoslavia, 1941-1945: occupation and collaboration, Stanford university press, Stanford (Cal.) 2001, pp. 751-778; D. B. MacDonald, Balkan Holocausts? Serbian and Croatian Victim-Centered Propaganda and the War in Yugoslavia, Manchester University Press, Manchester and New York 2003, pp. 170-171.
[5] T. Francesconi, Bersaglieri in Venezia Giulia, cit., p. 304; F. Molinari, Istria contesa. La guerra, le foibe, l’esodo, Mursia, Milano 1996, pp. 65-66; G. Barral, Borovnica ’45 al confine orientale d’Italia. Memoria di un ufficiale italiano, a cura di R. Timay, Inquadramento storico di R. Pupo, Ed. Paoline, Milano 2007, pp. 159-164.
[6] La principale fonte relativa all’episodio, e cioè il resoconto steso da un informatore alleato dopo una serie di colloqui con gli abitanti del luogo, è stata pubblicata, anche se non sempre in forma completa, da vari autori. Cfr. ad esempio E. Apih, Trieste, cit., pp. 163-164; il giornale «Il Piccolo» di Trieste nell’edizione del 30 gennaio 1995; R. Pupo, R. Spazzali, Foibe, cit., pp. 71-75; C. Cernigoi, Operazione «foibe» tra storia e mito, Kappa Vu, Udine 2005, pp. 287-289.
[7] E. Apih, Trieste, cit., p. 166.
[8] P. Meccariello, La Guardia di Finanza nella seconda guerra mondiale (1940-1945), Museo storico della Guardia di Finanza, Roma 1992; Roberto Spazzali, … l’Italia chiamò Resistenza politica e militare italiana a Trieste 1943-1947, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2003, testo di riferimento sull’insurrezione del CLN di Trieste del 30 aprile 1945. Ipotesi diverse sulla persecuzione dei finanzieri sono fornite da C. Cernigoi, Operazione «foibe», cit. pp. 41-46.
[9] A. Malgeri, L’occupazione di Milano e la liberazione, Edizioni del Comune di Milano, Milano 2005 (1a edizione 1947).
[10] Cfr. al riguardo le affermazioni contenute nei dispacci inviati dal Comitato centrale del Partito comunista sloveno al Comitato direttivo del Partito per il Litorale sloveno alla fine di aprile del 1945, pubblicate in R. Pupo, R. Spazzali, Foibe, cit., pp. 68-71.
[11] R. Kaltenegger, Zona d’operazione Litorale Adriatico, cit., pp. 314-317; T. Francesconi, Bersaglieri in Venezia Giulia, cit., pp. 306-308; F. Razzi, Lager e foibe in Slovenia, Editrice Vicentina, Vicenza 1992, pp. 27 passim; L. Rossi Kobau, Prigioniero di Tito 1945-1946. Un bersagliere nei campi di concentramento jugoslavi, Mursia, Milano 2001, pp. 26-34, G. Barral, Borovnica, cit., pp. 139-151.
[12] R. Pupo, Venezia Giulia 1945. Immagini e problemi, Libreria editrice goriziana, Gorizia 1992, pp.149-152.
[13] È orribile dirlo, e ciò non attenua affatto le responsabilità per i singoli casi, ma di tale natura sembra sia stato il trattamento standard riservato ai prigionieri degli eserciti del Tripartito arresisi alla fine della guerra sul fronte orientale. Ad esempio, nel solo teatro di operazioni compreso fra la Vistola e la linea Oder‑Neiße, degli oltre 800 mila i militari tedeschi fatti prigionieri dai sovietici ne morirono circa centomila in seguito alle disastrose condizioni di detenzione. Un esempio di queste condizioni fu il sovraffollamento dei due campi dell’area urbana di Breslavia, che giunsero a ospitare contemporaneamente oltre 300 mila prigionieri di guerra germanici, di cui circa il 20% morì in breve di fame o di malattie. Coloro che sopravvissero, furono organizzati in “battaglioni di lavoro” ed inviati ai lavori forzati nel profondo dell’URSS. Cfr. D. Artico, Trasferimenti forzati e controllo di polizia delle minoranze nazionali in Polonia occidentale, in Uomini e donne in fuga nel secondo dopoguerra, Atti del convegno tenutosi a Teramo nei giorni 27 e 28 Novembre 2007, in corso di pubblicazione e, più diffusamente, R. Overmans, Soldaten hinter Stacheldracht. Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs, Propyläen, Berlino, 2000.
[14] G. Fogar, Trieste in guerra 1940-1954. Società e Resistenza, Quaderni di «Qualestoria» 10, IRSML FVG, Trieste 1999, cit. p. 181.
[15] Cfr. la testimonianza rilasciata il 3 agosto 1990 da G. C. a Galliano Fogar e conservata presso l’archivio IRSML FVG. Brani significativi della testimonianza sono stati pubblicati in Foibe ed esodo, allegato a «Tempi e culture», II (1996-1997) n. 3, p. 45, nonché in R. Pupo, R. Spazzali, Foibe, cit., pp. 92-98.
[16] Cfr. al riguardo i fondi conservati presso l’archivio della Slovenia di Lubiana ed ampiamente utilizzati nei loro saggi da N. Troha, R. Pupo, R. Spazzali e G. Valdevit.
[17] La crisi di Trieste. Maggio-giugno 1945. a c. di G. Valdevit, cit.
[18] K. Colja, Il collaborazionismo nell’Adriatisches Küstenland: la vicenda dei domobranci (1943-1945) in M. Verginella, A. Volk, K. Colia, Storia e memoria degli sloveni del Litorale. Fascismo, guerra e resistenza, Quaderni di «Qualestoria» 7, IRSML FVG, Trieste 1994; B. Mlakar, Domobranstvo na Primorskem: (1943-1945), Ljubljana : Zalozba borec, 1982.
[19] Cfr., fra gli altri, G. Valdevit, Il dilemma Trieste., cit. pp. 96-99.
[20] Per una panoramica generale sul fenomeno dell’esodo, mi permetto di rinviare al mio Il lungo esodo, cit.; per una ricostruzione in alcuni tratti datata, ma assai puntuale, cfr. C. Colummi, L. Ferrari, G. Nassisi, G. Trani, Storia di un esodo. Istria 1945-1956, Irsml FVG, Trieste 1980; Per una prospettiva comparativa cfr. Esodi: trasferimenti forzati di popolazioni nel dopoguerra europeo, a c. di M. Cattaruzza, M. Dogo, R. Pupo.
[21] Per quanto riguarda la dimensione complessiva dell’esodo, nonché la distribuzione degli esuli per lingua e provenienza, cfr. sinteticamente gli studi di O. Mileta, Movimenti di popolazione nelle terre cedute alla Jugoslavia nell’ultimo conflitto mondiale. Ipotesi di quantificazione demografica, in Dopoguerra di confine, a c. di T. Catalan, G. Mellinato, P. Nodari, R. Pupo, M. Verginella, IRSML - Università di Trieste, Trieste 2007.
[22] Per una ricostruzione dettagliata della distruzione di Zara e delle sue motivazioni cfr. O. Talpo, Dalmazia. Una cronaca per la storia, cit., pp.1360–1429 e, con ampia documentazione fotografica, O. Talpo, S. Brcic, …Vennero dal cielo, II ed. ampliata, Palladino editore, Campobasso 2006. Per un’interpretazione alternativa cfr. A. Seferovic, Le fortezze volanti sopra Zara, serie di sei articoli pubblicati sul quotidiano di Zara «Slobodna Dalmacija», nei giorni 19, 20, 21, 23, 24 e 25 ottobre 1984.
[23] Cfr. al riguardo O. Moscarda Oblak, Instaurazione del potere popolare in Isria e a Rovigno. I verbali del Comitato popolare cittadino di Rovigno (1946), in CRS Rovigno, «Quaderni», vol. XVI, 2004, pp. 109-138; Ead., Instaurazione del potere popolare in Istria e a Rovigno. La seconda Assemblea del Comitato popolare cittadino di Rovigno, in CRS Rovigno, «Quaderni», vol. XVIII, 2006, pp. 115-139; M. Orlić, La creazione del potere popolare in Istria 1945-1948, in L. Bertucelli, M. Orlic, Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento, Ombre corte, Verona 2008, pp. 123-151; Ead., Poteri popolari e migrazioni forzate in Istria, in Uomini e donne in fuga nel secondo dopoguerra, Atti del convegno tenutosi presso l’Università di Teramo, 27-28 novembre 2007.
[24] M. Cattaruzza, L’esodo istriano: questioni interpretative, in «Ricerche di Storia Politica», I (1999), pp. 27-48; R. Pupo, Il lungo esodo, cit.
[25] Cfr. la Relazione sugli ultimi avvenimenti nella Venezia Giulia e sulle condizioni dei comunisti già membri delle sezioni locali del Partito Comunista Italiano, inviata clandestinamente a Togliatti nell’autunno del 1945. Il testo della relazione, il cui originale è conservato presso IG, b. 55/4, f. R, doc. 25, è stato pubblicato su «Tempi e culture», I (1997), n. 2, pp. 33-46.
[26] E. Sestan, Le argomentazioni e le pretese del dott. Smodlaka, in Id., Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale, ora ripubblicato a c. e con postfazione di G. Cervani, Del Bianco, Udine 1997, pp. 183-187.
[27] G. Nemec, Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunità in esilio. Grisgnana d’Istria 1930-1960, Libreria editrice goriziana, Gorizia 1998;Ead., Un lungo spaesamento. L’esperienza dei ceti rurali nel movimento dell’esodo dalla zona B, in s/paesati, ciclo di conferenze organizzato dal Teatro Miela, dal Teatro Stabile Sloveno e dal Dipartimento di storia e storia dell’arte dell’Università di Trieste fra il novembre 2000 e la primavera del 2001, ora pubblicato in «Qualestoria», XXXI (2003), 2, pp. 46-55; Ead., The Re-definition of Gender Roles and Family Structures among Istrian Peasant Families Faced with Urban Society in Trieste (1954-1964), in «Journal of Modern Italy», Special Issue Gender and the Private Sphere in Italy Since 1945 (vol. 9,1 Maggio 2004).
[28] T. Veiter, Soziale Aspekte der italienische Flucthtlinge aus den adriatischen Kustengebieten, in T. Mayer Maly, A. Nowak, T. Tomandl, Festschrift fur Hans Schmitz, Wien-Munchen 1967, vol. II, p. 280.
[29] Un terreno interessante di confronto può essere costituito dalla Polonia, posto che nel discutere degli scambi di popolazione con l’Ucraina la storiografia ha fatto uso di formule quali «costrizioni situazionali», o «circumstanzial forces», applicabili anche al caso istriano. Cfr. M. Waldenberg , Scambi di popolazione tra Polonia ed Unione Sovietica nel secondo dopoguerra, in Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento Europeo, a c. di M. Cattaruzza, M. Dogo, R. Pupo, cit, pp. 141-150; K. Kersten, Forced Migrations and the Transformation in Polish Society, in P. Ther, A. Siljak, Redrawing The Nations. Etning Cleansing in East-Central Europe 1944-1948, Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Lanham 2001, pp. 75-86.
[30] L. Drndic, Le armi e la libertà dell’Istria 1941-1943, EDIT, Fiume 1981.
[31] A. Visintin, L’Italia a Trieste. L’operato del governo militare italiano nella Venezia Giulia, 1918-1919, IRSML FVG, Libreria editrice goriziana, Gorizia 2000.
[32] L. Tavano, 1945: la crisi finale dell’unità della diocesi, in F. Dolinar, L. Tavano (a cura di), Chiesa e società nel Goriziano fra guerra e movimento di liberazione, Istituto di storia sociale e religiosa – Istituto di studi mitteleuropei, Gorizia 1997, pp. 273-284; Id., La diocesi di Gorizia 1750-1947, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2004, pp. 239-240.
[33] A. Kalc, L’emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia fra le due guerre ed il suo ruolo politico, in «Annales», VI (1996), n. 8
[34] S. Volk, Esuli a Trieste. Bonifica nazionale e rafforzamento dell’italianità sul confine orientale, Kappa Vu, Udine 2004